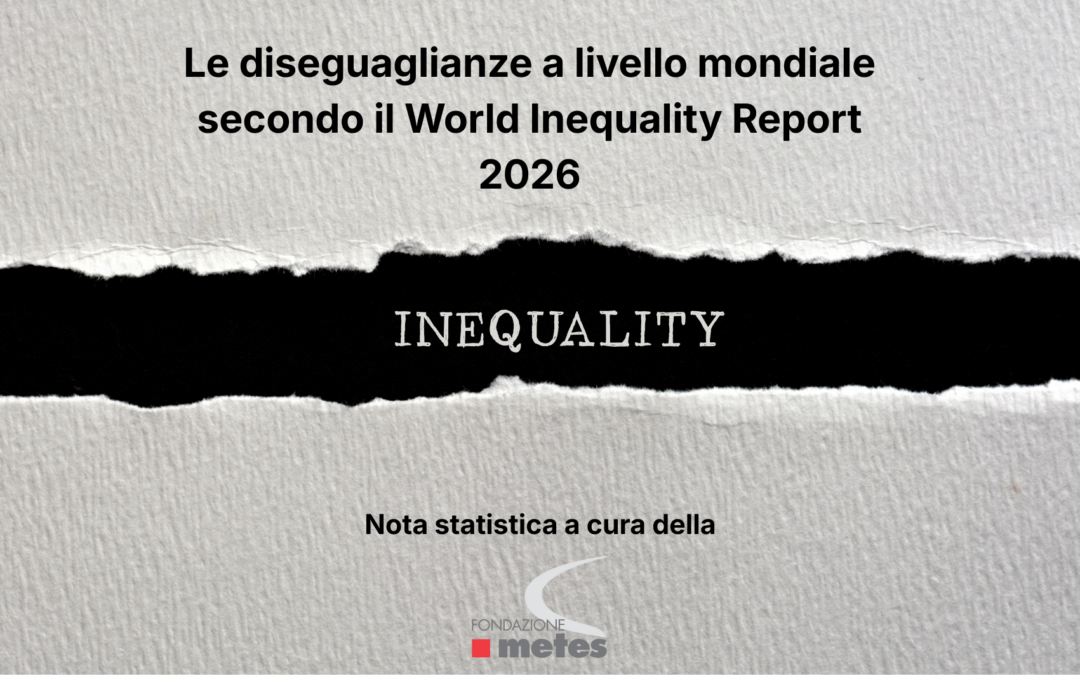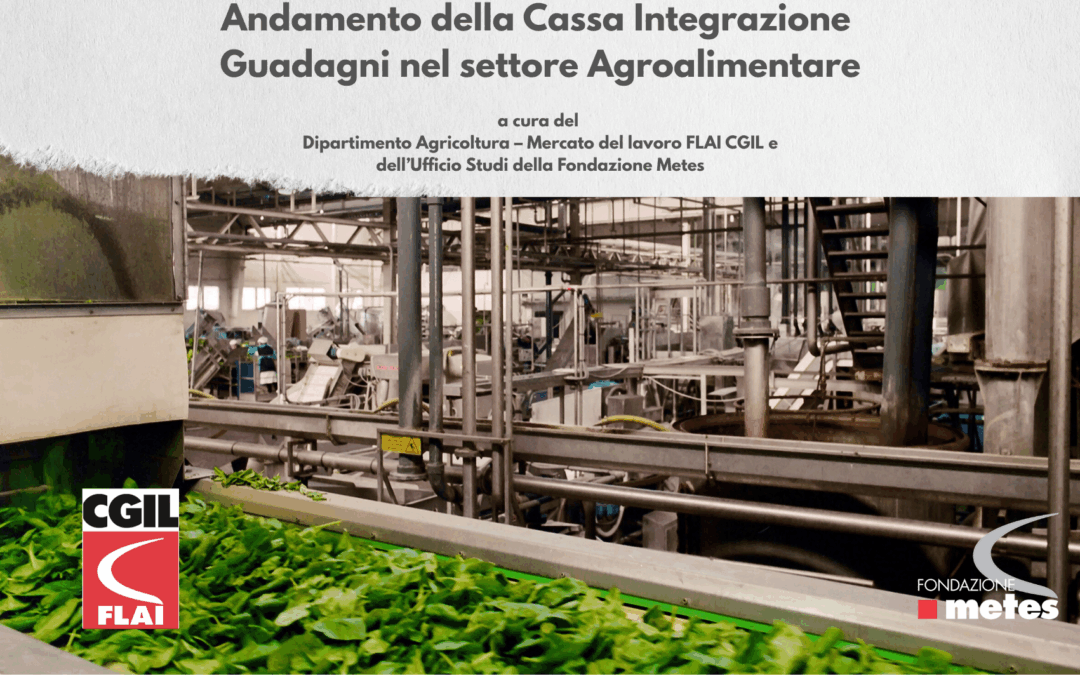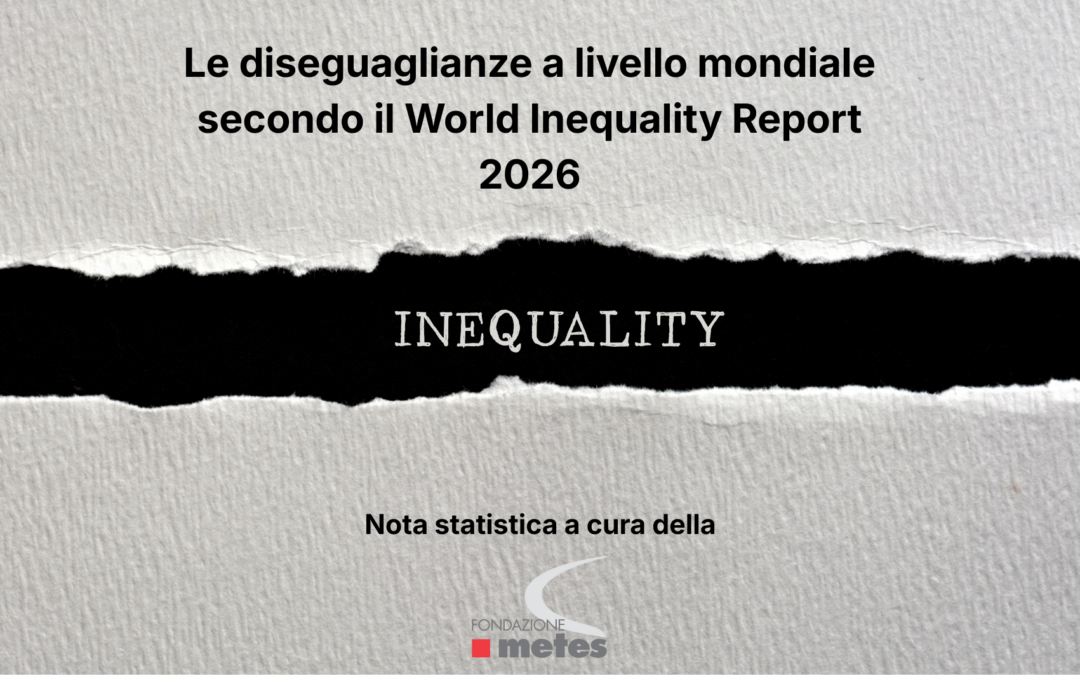
Gennaio 2026 | News, Note Statistiche
Il World Inequality Report 2026 (WIR 2026) rappresenta una preziosa fonte per analizzare le disuguaglianze che caratterizzano il XXI secolo: clima e ricchezza, diseguaglianza e genere, disparità di accesso all’istruzione e alla formazione, iniquità del sistema finanziario globale e sperequazioni territoriali.
Il 10% più ricco della popolazione mondiale percepisce un reddito complessivo superiore a quello del restante 90%, mentre la metà più povera detiene meno del 10% del reddito globale.
La metà più povera della popolazione mondiale è responsabile solo del 3% delle emissioni globali di carbonio, mentre il 10% più ricco contribuisce al 77% del totale.
A livello globale, le donne percepiscono poco più di un quarto del reddito da lavoro totale, una quota che è rimasta pressoché invariata dal lontano 1990.
La spesa media per l’istruzione pro capite nell’Africa subsahariana si attestava su soli 200 euro (a parità di potere d’acquisto, PPA), rispetto ai 7.400 euro in Europa e ai 9.000 euro in Nord America e Oceania.
Le diseguaglianze non hanno impatti solo economici e sociali ma condizionano fortemente la politica. Oggi, ad esempio, molti elettori con titoli di studio elevati ma con redditi relativamente bassi (ad esempio, insegnanti o infermieri) votano per la sinistra, mentre molti elettori con titoli di studio inferiori ma redditi relativamente più alti (ad esempio, lavoratori autonomi o camionisti) tendono a votare per la destra.
Secondo WIR 2026 analizzando gli andamenti della disuguaglianza nei vari Paesi emerge che le politiche possono ridurre le sperequazioni nella distribuzione della ricchezza. Il WIR 2026 mostra che, persino con aliquote modeste, un’imposta patrimoniale minima globale mirata esclusivamente ai super-ricchi (patrimoni > 100 milioni USD) potrebbe generare un gettito significativo anche con aliquote relativamente moderate. Le proposte formulate dal WIR 2026 confermano il valore della proposta avanzata dal segretario nazionale della CGIL, Maurizio Landini, di introdurre un contributo di solidarietà a carico delle circa 500 mila persone che in Italia detengono una ricchezza netta annua di oltre 2 milioni di euro.
Consulta la Nota Statistica completa

Dicembre 2025 | News, Note Statistiche
a cura del Dipartimento Agricoltura – Mercato del lavoro FLAI CGIL e dell’Ufficio Studi della Fondazione Metes
Nel 2024 risultano beneficiari di prestazioni di Cassa Integrazione Speciale Operai dell’Agricoltura (CISOA) 12.174 lavoratori. Rispetto allo scorso anno i beneficiari di prestazioni di CISOA in Italia sono aumentati di 1.082 unità (+9,8% rispetto al 2023). In particolare, nel 2024 sono state indennizzate poco meno di 180 mila di giornate (+8,4% rispetto al 2023) che hanno determinato l’erogazione complessiva di 9,6 milioni di euro (+13,5%).
Nel 2024 risultano beneficiari di indennità di disoccupazione agricola 512.309 lavoratori. Rispetto all’anno precedente i beneficiari di indennità di disoccupazione agricola in Italia sono diminuiti di 11.836 unità (-2,3% rispetto al 2023). In particolare, nel 2024 sono state indennizzate poco più di 64,5 milioni di giornate (-1,3% rispetto al 2023) che hanno determinato l’erogazione complessiva di 1,9 miliardi di euro (+1,1%).
Consulta la nota completa
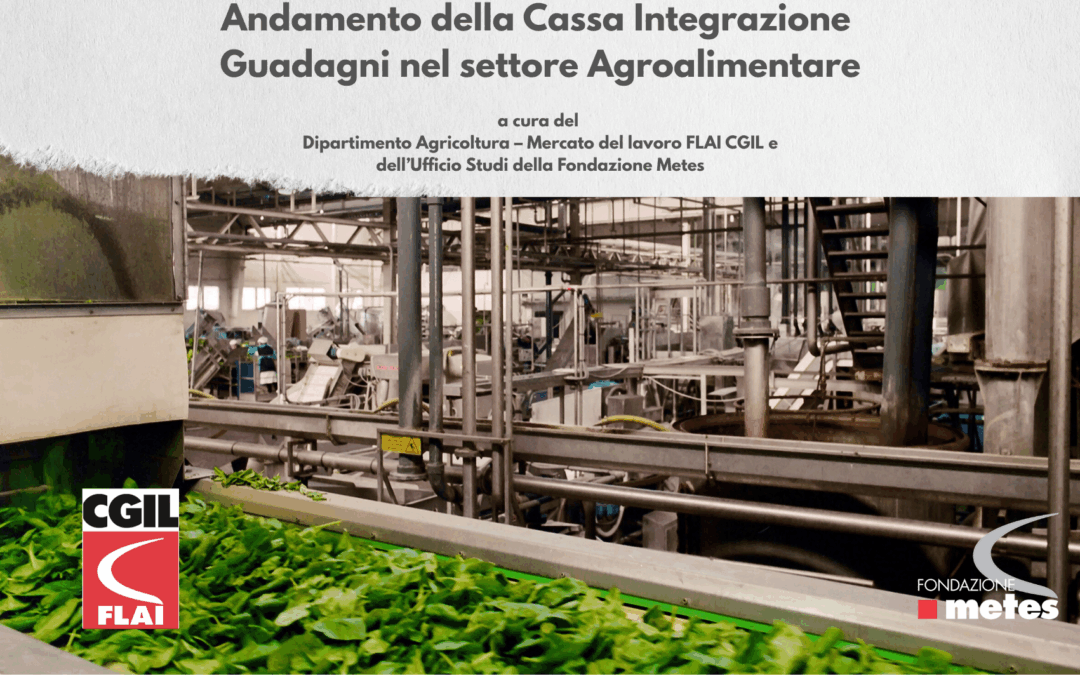
Novembre 2025 | cassa integrazione, News, Note Statistiche
a cura del Dipartimento Agricoltura – Mercato del lavoro FLAI CGIL e dell’Ufficio Studi della Fondazione Metes
Nel periodo gennaio – settembre 2025, si contano, nel complesso, 5.106.304 ore di cassa integrazione guadagni autorizzate nei primi otto mesi dell’anno per i settori dell’agroalimentare. Considerando che nello stesso periodo del 2024 sono state autorizzate 4.732.066 ore si rileva un incremento tendenziale del 7,9%.
Passando all’analisi del dettaglio settoriale anche per il periodo gennaio – settembre 2025 si osserva che:
- per “Agricoltura, caccia e relativi servizi” le ore di cassa integrazione autorizzate nel periodo gennaio – settembre 2025 sono pari a 375.564. Considerando che nello stesso periodo del 2024 sono state autorizzate 112.204 ore si rileva un incremento tendenziale del 234,7%;
- per “Industrie alimentari e delle bevande” le ore di cassa integrazione autorizzate nel periodo gennaio – settembre 2025 sono pari a 4.730.740. Considerando che nello stesso periodo del 2024 sono state autorizzate 4.619.862 ore si rileva un incremento tendenziale del 2,4%.
Consulta la Nota completa

Novembre 2025 | News, Note Statistiche
La distribuzione della superficie irrigabile e irrigata sul territorio nazionale ha conseguenze rilevanti dal punto di vista produttivo, qualitativo e ambientale. Le aree con una maggiore disponibilità di infrastrutture irrigue -concentrate prevalentemente nel Nord – sono anche quelle in cui si concentra quantitativamente e in valore la nostra produzione agricola nazionale. Nello specifico, per quanto riguarda la qualità, alcune colture agricole offrono un rendimento migliore se irrigate adeguatamente; dal punto di vista ambientale, invece, un’irrigazione più intensiva presenta diverse criticità. L’aumento dei terreni irrigati può, infatti, comportare un uso eccessivo delle risorse idriche locali, un’intensa lavorazione del suolo e un maggiore rischio idrogeologico.Il Dialogo strategico sul futuro dell’agricoltura nell’UE e la Comunicazione UE “Una visione per l’agricoltura e l’alimentazione” (2025), considerano l’acqua e l’irrigazione temi centrali per garantire un’agricoltura sostenibile. È necessario usare l’acqua in modo più efficiente, riducendo gli sprechi e migliorando la gestione irrigua, viene evidenziata l’importanza di ridurre l’inquinamento delle acque, limitando l’uso di fertilizzanti e pesticidi nocivi per ecosistemi e falde. Vengono promosse innovazioni tecnologiche e pratiche “water-smart”, come l’irrigazione di precisione, sistemi di monitoraggio digitale e soluzioni naturali per aumentare la ritenzione idrica del suolo. Si incoraggia inoltre la diffusione di colture più resistenti allo stress idrico e il sostegno tecnico e finanziario agli agricoltori nelle zone soggette a siccità.
Consulta la nota completa

Ottobre 2025 | News, Note Statistiche
Nel 2023 il valore aggiunto generato dall’economia non osservata, ovvero dalla somma di economia sommersa e attività illegali, si è attestato a 217,5 miliardi di euro, registrando una crescita del 7,5% rispetto all’anno precedente (quando era 202,4 miliardi). In termini di incidenza, il peso del valore aggiunto da economia non osservata sul PIL è leggermente aumentato, attestandosi al 10,2% rispetto al 10,1% del 2022.
Nel settore agricoltura, silvicoltura e pesca l’economia sommersa vale 5,9 miliardi di euro e pesa per il 14,9% sul totale del valore aggiunto generato dal settore.
La crescita dell’economia non osservata è stata determinata principalmente dall’andamento del valore aggiunto generato dall’utilizzo di “lavoro irregolare”, che ha segnato un aumento di 7,8 miliardi di euro (+11,3%) rispetto al 2022.
Per quanto riguarda l’economia sommersa, nel 2023, il valore si è attestato a 197,6 miliardi di euro, in crescita del 6,6% (+6,7 miliardi) rispetto al 2022. Il suo peso sul PIL rimane sostanzialmente stabile al 9,2% (era il 9,1% nel 2022). I settori nei quali il peso del sommerso economico è maggiore sono gli “Altri servizi alle persone” (32,4% del valore aggiunto del comparto), il “Commercio, trasporti, alloggio e ristorazione” (18,8%), le “Costruzioni” (16,5%), l’“Agricoltura, silvicoltura e pesca” (14,9%) e i “Servizi professionali” (13,7%).
La dimensione del valore aggiunto generato da sotto-dichiarazione ha un ruolo significativo per gli “Altri servizi alle persone” (12,2% del totale del valore aggiunto del settore), per il “Commercio, trasporti, alloggio e ristorazione” (11,1%) e le “Costruzioni” (10,3%).
Il valore aggiunto generato dall’impiego di lavoro irregolare presenta una maggiore incidenza negli “Altri servizi alle persone” (19,7% del valore aggiunto totale), anche per l’inclusione del lavoro domestico.
Il tasso di irregolarità, calcolato come incidenza percentuale delle unità di lavoro a tempo pieno (ULA) non regolari sul totale, risulta in aumento nell’ultimo anno, attestandosi al 12,7%, dopo il 12,5% stimato nell’anno precedente. L’agricoltura, silvicoltura e pesca, dove è irregolare più di una unità di lavoro dipendente a tempo pieno (ULA) su tre, è il secondo settore in termini di incidenza delle unità di lavoro irregolari (35,0% del totale delle ULA dipendenti). In particolare, nel settore “Agricoltura, silvicoltura e pesca” sono 203mila le unità di lavoro in condizione di non regolarità (146mila dipendenti e 57mila indipendenti).
Consulta la nota completa

Ottobre 2025 | News, Note Statistiche
Nel 2024 la spesa media mensile totale delle famiglie residenti in Italia è pari a 2.755 euro in valori correnti e rimane sostanzialmente invariata rispetto ai 2.738 euro registrati nel 2023 (+0,6%). Tra il 2019 e il 2024 il valore della spesa per consumi delle famiglie è, quindi, aumentato del 7,6% a fronte di un’inflazione, misurata sullo stesso arco temporale dall’Indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA), del 18,5%.
Spesa media mensile delle famiglie per Prodotti alimentari e bevande analcoliche
Il valore della spesa media mensile delle famiglie per l’acquisto di Prodotti alimentari e bevande analcoliche che nel 2024 è pari a 532,85 euro.
Dall’analisi territoriale dei trend della spesa media mensile delle famiglie destinata all’acquisto di Prodotti alimentari e bevande analcoliche emerge che il maggiore incremento si registra nel Nord-Est dove il valore della spesa media mensile delle famiglie per l’acquisto di Prodotti alimentari e bevande analcoliche aumenta del 2,0%.
Nel 2024 le regioni con la spesa media mensile per l’acquisto di Prodotti alimentari e bevande analcoliche più elevata sono Campania (625,45 euro) e Sicilia (599,36 euro), mentre Sardegna e Puglia sono quelle con la spesa più contenuta, rispettivamente 390,63 e 455,63 euro mensili. In termini di incidenza, la quota più elevata di spesa per l’acquisto di Prodotti alimentari e bevande analcoliche si registra in Calabria (28,2%) e in Campania (27,8%) a fronte del 19,2% osservato a livello nazionale. La minore incidenza della spesa media mensile per l’acquisto di Prodotti alimentari e bevande analcoliche si rileva invece che nella provincia di Trento (15,5%) e in quella di Bolzano (13,8%).
Andamento dei consumi di Generi alimentari e bevande non alcoliche
Nel 2024, così come nel 2023, circa un terzo delle famiglie dichiara di aver limitato in quantità e/o qualità, rispetto a un anno prima, la spesa per cibo (31,0%, era il 31,4% nel 2023) e per bevande (33,4%, dal 33,8%).
La crescita registrata nei prezzi dei beni alimentari ha determinato una compressione anche in chiave qualitativa delle scelte di consumo. La crescita registrata negli ultimi anni della quota delle vendite realizzate dal canale distributivo Discount può essere, infatti, interpretato come il segnale della crescente difficoltà affrontata dalle famiglie italiane a porre una adeguata attenzione agli standard qualitativi nelle scelte alimentari. Continuano, infatti, a perder terreno i piccoli negozi di prossimità sia appartenenti alle grandi catene (libero servizio e superette -3,9%) che ancor più quelli indipendenti (negozi tradizionali -4,8%). Mentre gli ipermercati registrano lievi incrementi di fatturato (+0,8% rispetto al 2023) guadagnano, invece, terreno i supermercati e i discount (rispettivamente +2,5% e +1,5% i fatturati rispetto al 2023).
Consulta la Nota completa